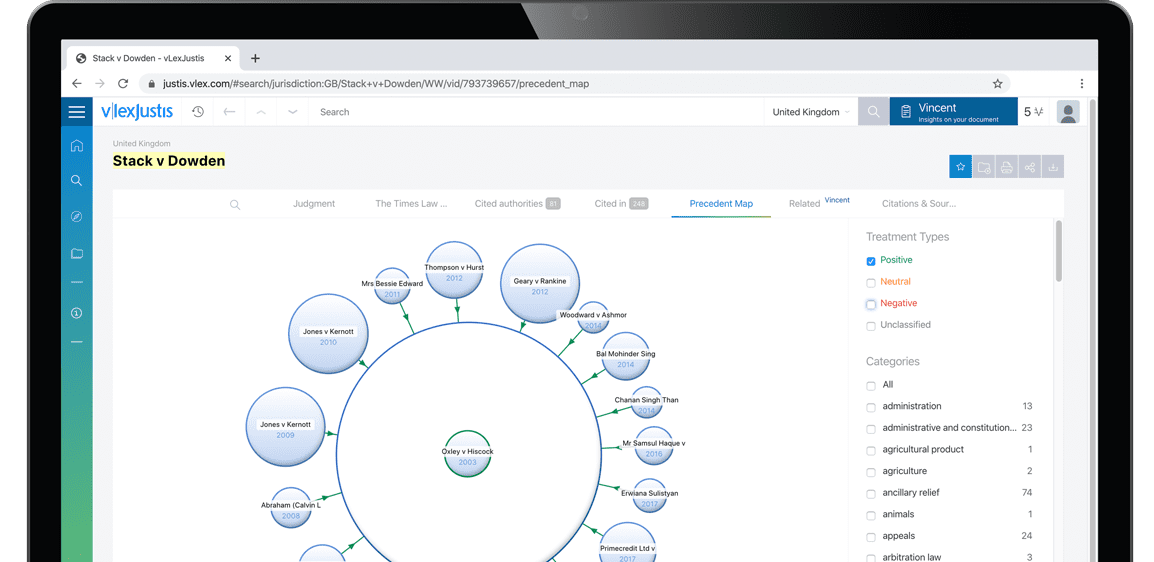La geografia istituzionale post- Lisbona e la posizione dell'Italia
| Author | Rocco Cangelosi; Marco Peronaci |
| Position | Ambasciatore, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea (2004-2008), Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica; Funzionario diplomatico, Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea |
| Pages | 55-71 |
Page 55
1. Sono trascorse poche settimane dal Consiglio europeo di dicembre, l'ultimo sotto Presidenza francese, che ha definito il ruolino di marcia1 per l'attesa entrata in vigore del Trattato di Lisbona2, dopo l'ennesima pausa di riflessione imposta dal "no" irlandese dell'estate scorsa. L'Europa, scossa dalla doppia crisi del conflitto in Georgia e del crack finanziario mondiale, ha dimostrato buone capacità di reazione sotto la leadership reattiva e volontarista del Presidente Sarkozy. In un'America sotto lo shock del fallimento bancario della Lehman Brothers e del crollo di Wall Street, ed assorbita dalla storica transizione elettorale al termine della presidenza Bush, sono scaturiti da Bruxelles gli impulsi e le decisioni che hanno permesso di gestire i colpi della crisi ed impostare le necessarie contromi- sure a livello interno ed internazionale. Per una fortunata coincidenza storica, legata al calendario delle presidenze a rotazione, l'Europa ha beneficiato di una presidenza unica e di una forte proiezione internazionale. Ê stato come poter disporre delle nuove istituzioni di Lisbona, senza avere ancora il Trattato: l'anticipazione di un futuro possibile3, il collaudo delle nuove necessarie istituzioni. Page 56
Gli ultimi mesi hanno nuovamente dimostrato, al di là di ogni possibile confutazione, che l'Unione ha bisogno dei correttivi istituzionali del Trattato di Lisbona e che la stragrande maggioranza degli Stati membri intende in un modo o nell'altro perseguire sino alla fine del processo l'entrata in vigore del Trattato di riforma4. Non ci sono, dovrebbe essere ormai evidente, altri "piani B", perché l'accordo firmato in Portogallo il 13 dicembre 2007 costituisce ancora per i 27 Stati membri il punto irrinunciabile di equilibrio del lunghissimo negoziato istituzionale europeo. Come ha sottolineato a più riprese il Presidente di turno dell'Unione in occasione delle nuove ratifiche successive al "no" dublinese, senza Lisbona non c'è che Nizza, da applicare in tutte le sue parti e senza correttivi: meno Commissari per tutti5, meno parlamentari europei per molti6, minore efficienza, capacità decisionale e legittimità democratica per tutta l'Unione. Si può discutere sulla giustezza di tale impostazione, si può deplorare il ritardo che non ha consentito di far entrare in vigore il Trattato prima del rinnovo del Parlamento europeo il prossimo giugno7, si può rimpiangere il mancato referendum europeo che avrebbe potuto sbloccare in via politica la situazione delle ratifiche, ponendo Dublino di fronte alla scelta tra stare dentro o stare fuori. Ma non si può non convenire sulla dura realtà che, sia detto con il dovuto riguardo per tutti, un'Unione con alla sua guida un Paese di ridotte dimensioni e risorse difficilmente avrebbe potuto far fronte con pari efficacia al doppio shock degli ultimi mesi. Page 57
La seconda considerazione riguarda una verità antica, riproposta dall'attualità recente: è in tempi di crisi che si costruisce l'Europa, è nelle congiunture più avverse che si forgiano le decisioni che determinano il sentiero dei futuri sviluppi istituzionali. Siamo pertanto convinti che sia necessario sviluppare da subito un supplemento di riflessione sul Trattato di Lisbona ancora non ratificato, armarsi di una visione "lunga" dell'evoluzione del panorama istituzionale dell'Unione, che muova dal presupposto dell'approvazione del Trattato, ma che sappia anche iniziare a guardare oltre. Né atto di fede, né manifestazione di avventato coraggio, ragionare sul "dopo-Lisbona" serve oggi a superare la fascia acuta di turbolenza della doppia crisi; e, soprattutto, ci consente di riavvicinarsi all'Europa, al suo sogno e al suo progetto, cercando di immaginare in concreto l'Unione come potrebbe essere e come sarà, e definendo in questo contesto le linee di una possibile posizione italiana.
Va altresì riconosciuto che l'auspicata entrata in vigore del Trattato di Lisbona8 non dissiperà, tutto d'un tratto, ogni nube o incertezza sul futuro quadro di funzionamento dell'Unione. Il panorama istituzionale post-Lisbona resta infatti soggetto ad una forte alea in ragione sia delle effettive modalità di attuazione delle nuove disposizioni, sia delle personalità che saranno scelte per occu- pare e interpretare i nuovi incarichi. Il Trattato potenzia infatti il Consiglio europeo ed il Parlamento, complica la percezione del Consiglio e del ruolo del Paese di presidenza semestrale, pone un interrogativo sul profilo futuro della Commissione e muta significativamente la natura dell'Alto rappresentante, la cui nuova duplice funzione (double hatting) si fonda su due distinte linee di legittimità: ancorata alle istruzioni consiliari per gli aspetti della PESC/PESD, sotto l'autorità della Commissione ed il controllo del Parlamento europeo per le materie comunitarizzate.
In un tale contesto ad alta fluidità, l'Italia dovrà accuratamente valutare le sue opzioni ed il suo posizionamento sullo scacchiere europeo, sulla base di una visione strategica di lungo termine che definisca gli obiettivi tattici di breve e medio periodo in coerenza con la sua storia e vocazione europea. Una breve panoramica sugli ultimi due decenni di negoziato istituzionale europeo potrà aiutarci a contestualizzare il giudizio sulle prospettive offerte dal Trattato di Lisbona9 allo sviluppo del progetto europeo e, all'interno di questo, del ruolo e delle possibilità offerte dal nostro Paese.
2. I due decenni a cavallo del Terzo millennio hanno visto svilupparsi una fase di negoziato istituzionale europeo particolarmente intensa e variata. Da Maastricht a Lisbona siamo stati testimoni di una linea quasi mai interrotta di revisione delle regole e degli assetti europei. Il rilancio del progetto politico Page 58 europeo dopo il crollo del Muro di Berlino ha portato agli europei la moneta unica, la cittadinanza ed un primo disegno dell'Unione politica, un'entità nuova e originale10, diversa al tempo stesso dalla Comunità delle origini e dalla Federazione.
Il carattere novatore ed embrionale dell'Unione politica e monetaria delineata nel 1992, si intreccia nel successivo quinquennio olandese11 con la possente spinta verso l'allargamento. Con il Trattato di Amsterdam, nel 1997, l'Europa affronta e vince la sfida dell'apertura ad Est e Sud, la quinta e più formidabile tornata di adesioni che ha caratterizzato il processo europeo. La storica e sanguinosa frattura interna all'Europa, lascìto avvelenato del XX secolo, è avviata a ricomposizione: un'Europa già lacerata in due e divisa in un mosaico di Stati, può iniziare a concepirsi come attore geo-politico potenziale12. Ma alto è il tributo da pagare in termini di coesione e solidità interna del progetto dell'Unione: l'accordo che suggella con successo il grande allargamento dell'Europa conduce ad un compromesso al ribasso (non sarà né il primo, né l'ultimo nella vicenda europea) sui tre punti dell'estensione del voto a maggioranza (ridotta al minimo); della cooperazione rafforzata (limitata essenzialmente al solo primo pilastro); e della ponderazione dei voti e della composizione della Commissione (rimandati a tempi migliori). Sono i cosiddetti "avanzi" (left-overs) di Amsterdam, i nodi critici irrisolti da cui sarebbe presto ripartito il negoziato istituzionale.
La procedura di ratifica di Amsterdam non era ancora conclusa che già si riapriva nelle diverse capitali europee il dibattito sui necessari correttivi istituzionali da apportare all'Europa. Non va sottaciuto il significativo ruolo di impulso e di visione politica fornito dall'Italia nei complessi anni che portarono al sia pur insufficiente Trattato di Nizza13. Dopo il quinquennio olandese, il nostro Paese spinse con determinazione per far sì che, assieme alla soluzione dei tre left-overs di Amsterdam, i negoziati istituzionali fossero estesi per includere sia le cooperazioni rafforzate (d'intesa con la Germania), sia i primi progressi registrati nella PESD (d'intesa con il Benelux), sia un avvio di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (d'intesa con la Spagna). Ma c'è di più. Fu sempre la stretta collaborazione italo-tedesca, a cui si aggiunsero poi la Francia ed il Benelux, che permise di negoziare la fondamentale dichiarazione sui seguiti di Nizza, in base alla quale si sanciva l'impegno ad avviare un dibattito Page 59 strutturato sul futuro dell'Europa, l'embrione di quel processo costituzionale europeo che avrebbe condotto da Laeken14 (2001) al Trattato costituzionale firmato a Roma nel 200415.
Gli sforzi per superare l'insoddisfacente compromesso di Nizza diedero avvio ad una fase istituzionale di grande interesse. Il lungo e complicato "cantiere" per le riforme europee, che ha generato la Costituzione e si è infine chiuso con l'accordo di Lisbona dell'autunno 2007, può essere diviso in quattro tappe distinte: i) i lavori della Convenzione; ii) la Conferenza intergovernativa (CIG) del 2004 e il progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; iii) il fallimento delle ratifiche e la susseguente pausa di riflessione nel 2005-2006; iv) e, infine, la ripresa del processo istituzionale con l'accordo nel giugno 2007 sul Trattato di riforma e la rapida CIG "attuativa" per redigere il testo tra il luglio e l'ottobre 2007. In realtà, tra l'avvio dei lavori della Convenzione e l'accordo sul Trattato di Lisbona si è assistito ad una sorta di grande ondata, accompagnata da un forte riflusso, una specie di movimento in due tempi, di azione-reazione.
La prima fase, caratterizzata dall'impronta squisitamente "anti-CIG" dello spirito convenzionale, ha tentato una politicizzazione del progetto europeo tramite il nuovo metodo del negoziato aperto e ibrido (miscela di intergovernativo e sopranazionale), la mobilitazione dei simboli (bandiera, inno e moneta comune), la valorizzazione della Carta dei diritti e la preparazione di un progetto di trattato denominato Costituzione, termine evocatore e ad alta intensità...
To continue reading
Request your trial